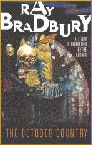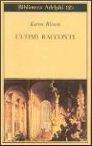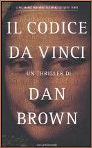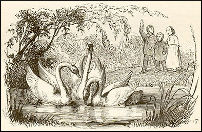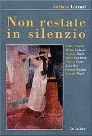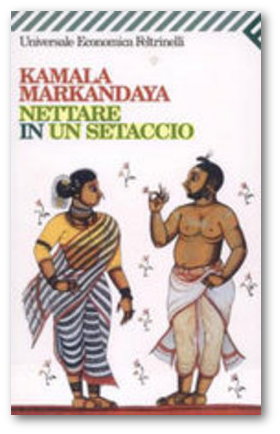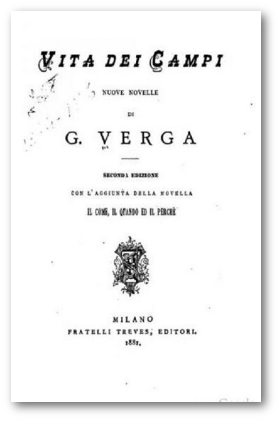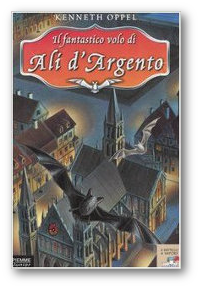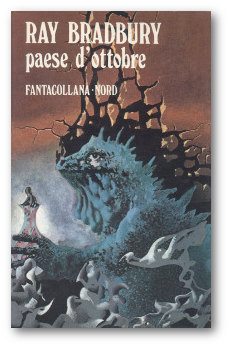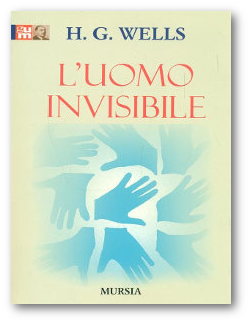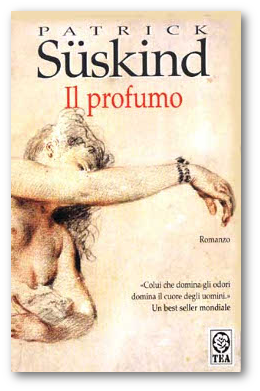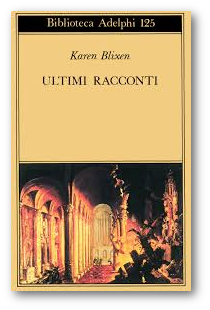PERLE RARE
antologia sull'esperienza della diversità
a cura di Paola Elia Cimatti
PREFAZIONE
Segnali luminosi fanno ritrovare la strada nell'oscurità:
a questo servono le parole.
La percezione della diversità non si può mai dire perché nessuno la capisce e viene a mancare il linguaggio: si finisce così per viverla di nascosto,
cercando di renderla invisibile, anche se è ben visibile a tutti.
Ho raccolto in queste pagine stralci e recensioni di opere letterarie significative,
che parlano di albinismo esplicitamente oppure per analogia.
Per smuovere la consapevolezza e la riflessione,
che agiscano come cura di sé,
o semplicemente ... per bellezza
Questa antologia non sarebbe stata possibile senza la collaborazione di amici e amiche di vaste letture che mi hanno segnalato testi da loro incontrati.
Ringrazio Guido Armellini, Cinzia Cimatti, Carla Mazzoni, Elettra Nerbosi, Donatella Pannacci, Vittoria Ravagli e tutte/i coloro che mi hanno dato suggerimenti e attenzione.
Paola Elia Cimatti
INTRODUZIONE
Alla consapevolezza che sta maturando intorno alle problematiche dell’albinismo, vorrei aggiungere il contributo che la letteratura e le scienze umane possono dare, in particolare riguardo all’elaborazione emotiva e immaginativa della propria condizione.
Può essere utile incontrare personaggi albini, o comunque segnati da una diversità, vedere come hanno reagito di fronte alle varie situazioni della vita, come sono riusciti a elaborare le ferite che la loro condizione (inevitabilmente) comporta.
Non dimentichiamo che da tali fonti proviene la maggior parte del sapere di cui psicologi, insegnanti e operatori di scienze dell’educazione possono avvalersi: è a loro che in particolare mi rivolgo.
Propongo quindi a puro titolo di esempio alcuni libri in cui si parla di albinismo (o di altra condizione rara). Si tratta prevalentemente di classici della letteratura, reperibili nelle principali lingue europee in diverse edizioni. È anzi sorprendente che una condizione così rara e sconosciuta ai più abbia tanto sollecitato l’immaginazione degli scrittori.
• Melville H. - Moby Dick (il cap. 42 è una vera “enciclopedia dell’albinismo”, incentrata sul colore bianco);
• Brown D. - Il codice Da Vinci – The Da Vinci Code (Si consiglia il libro, non il film, dove la storia del personaggio albino non viene raccontata);
• Hegi U. – Come pietre nel fiume – Stones from the river (Storia di una ragazza nana che riesce a costruirsi una vita a propria misura);
• Markandaya K. - Nettare in un setaccio – Nektar in a sieve (romanzo realistico su un bambino albino in un villaggio dekll’India);
• Wells H.G. - L’uomo invisibile – The invisible man;
• Oppel K. – Il fantastico volo di Ali d’Argento – Silverwings (fiaba)
• Genovesi F. – Chi manda le onde
• La leggenda di Azzurrina (bambina albina che la madre tentò di far apparire normale tingendole i capelli), per cui si consiglia una visita al Castello di Montebello (Rimini) segnalo la fiaba di A. Nanetti e il testo di A. Lorenzi nel libro “Non restate in silenzio”.
• Racconti inediti sul vissuto della diversità: disagi e risorse, orrore e splendore.
Nuovi Racconti è il seguito dell'antologia Perle Rare, perché dalla lettura degli autori citati può nascere il desiderio di una propria personale elaborazione.
Chi volesse provarci, può inviare il suo racconto ad albalapilla@albinismo.it
ORRORE E SPLENDORE
La storia è raccontata da Enoch, capo della famiglia e bisnonno del bambino.
E poco dopo mio figlio Matusalemme diede moglie a suo figlio Lamech: ella rimase incinta e partorì un figlio maschio. E il suo corpo era bianco come la neve e rosso come un bocciolo di rosa: i suoi capelli in lunghi riccioli erano bianchi come la lana e gli occhi erano molto belli.. E quando aprì gli occhi, illuminò tutta la casa come il sole e la casa intera era splendente. Subito dopo, si alzò fra le mani della levatrice, aprì la bocca e si mise a conversare con il Signore della Giustizia.
Suo padre Lamech si spaventò e scappò via: corse da suo padre Matusalemme e gli disse:”Mi è nato un bambino strano, diverso da un figlio di uomo e non simile a nessun: assomiglia ai figli del Dio del cielo. La sua natura è diversa e non è come noi. I suoi occhi sono come i raggi del sole e il suo portamento è glorioso. Mi sembra che non sia veramente mio figlio, ma degli angeli, e ho paura che sulla terra stia per accadere una catastrofe. E ora, padre mio, ti prego e ti imploro: vai da Enoch, nostro padre e fatti dire da lui la verità, perché il suo posto è fra gli angeli.
E come Matusalemme udì le parole di suo figlio, corse da me dall’altra parte del mondo, perché aveva sentito dire che ero là: gridò forte e io sentii la sua voce e gli venni incontro dicendo:: “Guarda, sono qui, figlio mio, per quale motivo sei venuto da me?” E lui rispose dicendo:”Per una grande angoscia sono venuto da te, per una visione sconvolgente ti ho cercato. E adesso, padre, ascoltami: a Lamech mio figlio è nato un bambino: non assomiglia a nessuno, la sua natura non è quella dell’uomo, il suo colore è più bianco della neve e più rosso di un bocciolo di rosa, ha i capelli più candidi della lana candida, gli occhi come raggi di sole, quando ha aperto gli occhi ha illuminato tutta la casa. Si è alzato fra le mani della levatrice, ha aperto la bocca e benedetto il Dio del cielo. E suo padre Lamech si è spaventato ed è corso da me, e non crede che sia figlio suo, ma che sia della famiglia degli angeli del cielo. E io sono venuto da te perché credo che tu conosca la verità.”
E io, Enoch, gli risposi dicendo: “<< il Signore farà una cosa nuova sulla terra: ho avuto una visione e ti faccio sapere che nella generazione di mio padre alcuni angeli del cielo trasgredirono la parola del Signore. E, ascolta, commisero peccato e trasgredirono la legge, si unirono alle donne e peccarono con loro, ne presero alcune come mogli ed ebbero figli da loro. Ed essi faranno nascere sulla terra giganti non secondo lo spirito ma secondo la carne, e ci sarà una grande punizione sulla terra: la terra verrà ripulita di tutte le impurità. Sì: verrà una grande distruzione su tutta la terra e ci sarà un diluvio e una grande catastrofe per un anno. E questo figlio che è nato nella tua famiglia sarà risparmiato, e i suoi tre figli con lui, mentre tutti gli uomini della terra moriranno. E adesso vai a dire a tuo figlio Lamech che quello che gli è nato è davvero suo figlio e lo chiami Noè. Egli rimarrà, egli e i suoi figli saranno salvati dalla distruzione che verrà sulla terra durante la sua vita. E dopo questo, ci sarà ancora più ingiustizia di quella che c’era prima sulla terra Io conosco i misteri dei santi, perché Egli, il Signore, me li ha rivelati.”
Libro di Enoch, Apocalisse 1-14
LA DIVERSITÀ RACCONTATA IN MODO REALISTICO
Una donna brutta non ha a disposizione nessun punto di vista superiore da cui poter raccontare la propria storia.. Non c’è prospettiva d’insieme. Non c’è oggettività. La si racconta dall’angolo in cui la vita ci ha strette, attraverso la fessura che la paura e la vergogna ci lasciano aperta giusto per respirare, giusto per non morire.
[…] Io sono brutta. Proprio brutta.
Non sono storpia, per cui non faccio nemmeno pietà.
[…] Mia madre si è messa a lutto quando sono nata…
La vita accanto, Mariapia Veladiano - Giulio Einaudi Editore

LA DIVERSITÀ COME CHIAVE DI LETTURA
“”E’ posseduto dal demonio”“Impossibile! E’ assolutamente impossibile che un lattante sia posseduto dal demonio…. Ha forse un cattivo odore?”“Non ha nessun odore”, disse la balia.“Ecco, vedi? Questo è un segno inequivocabile. Se fosse posseduto dal demonio dovrebbe puzzare.”E per tranquillizzare la balia e nel contempo dar prova del proprio coraggio, Terrier sollevò il canestro e se lo mise sotto il naso “Non sento niente di particolare”, disse, dopo aver annusato per un momento “ad ogni modo, mi sembra che dalle fasce provenga un certo odore.”“Non è questo”, disse la balia, brusca, e allontanò il canestro da sé. “i suoi escrementi hanno un buon odore. E’ lui, il bastardo, che non ha odore.”“Perché è sano”, gridò Terrier, “perché è sano, ecco perché non ha odore!. Soltanto i bambini malati hanno odore. Perché dovrebbe puzzare? Puzzano i tuoi figli?”“No”, disse la balia. “I miei figli hanno l’odore che tutti i bambini devono avere”“Dunque tu affermi di sapere che odore dovrebbe avere un bambino, che comunque è pur sempre - questo vorrei ricordartelo, tanto più quando è battezzato – una creatura di Dio? “”Sì”, disse la balia, “questo lattante mi fa ribrezzo perché non ha l’odore che i bambini devono avere.”“Ma dimmi, per favore, : che odore ha un lattante quando ha l’odore che tu ritieni debba avere? Eh?”La balia esitò. Sapeva bene che odore avevano i lattanti, lo sapeva benissimo, ne aveva nutriti, cullati, curati, baciati già a dozzine… di notte poteva trovarli a naso, l’odore del lattante l’aveva chiaro anche adesso nel naso. Ma non l’aveva mai definito con parole.“Dunque”, cominciò la balia, “non è molto facile da dire perché…perché non hanno lo stesso odore dappertutto, benché dappertutto abbiano un buon odore, padre, capisce, prendiamo i piedi ad esempio… lì hanno un odore come di pietra calda liscia…no, piuttosto di ricotta,… oppure di burro, di burro fresco, sì, proprio così, sanno di burro fresco. E i loro corpi hanno l’odore di…di una galletta quando è inzuppata nel latte.
E la testa, in alto, dietro, dove i capelli fanno la rosa,… hanno un odore di caramello, così dolce, così squisito. Una volta sentito questo odore bisogna amarli, che siano figli propri o di altri. E questo è l’odore che devono avere i neonati, questo e nessun altro. E se non hanno questo odore, se sulla testa non hanno nessun odore, ancor meno dell’aria fresca, come questo qui, il bastardo, allora...allora..."
Con il poco che c’era di olii di fiori, di acque e di spezie, un profumiere medio non avrebbe potuto fare grandi cose. Tuttavia Grenouille, al primo fiuto, capì che le sostanze presenti erano più che sufficienti per i suoi scopi. Non voleva creare un grande profumo; non voleva miscelare un’acquetta di prestigio, qualcosa che emergesse dal mare della mediocrità e ammansisse la gente. Le comuni essenze di neroli, eucalipto e foglie di cipresso dovevano soltanto nascondere il vero profumo che si era proposto di creare: il profumo dell’umano.Anche se per il momento sarebbe stato soltanto un cattivo surrogato, voleva appropriarsi dell’odore degli uomini, che lui stesso non possedeva.. Certo non esisteva l’odore degli uomini, così come non esisteva il volto umano. Ogni uomo aveva un odore diverso, nessuno lo sapeva meglio di Grenouille, che conosceva migliaia e migliaia di odori individuali e distingueva al fiuto gli esseri umani già dalla nascita.. E tuttavia esisteva una nota fondamentale dell’odore umano, del resto abbastanza semplice: una nota fondamentale di sudore grasso, di formaggio acidulo, ugualmente propria a tutti gli uomini e al di sopra della quale, più raffinate e più isolate, aleggiavano le nuvolette di un’un’aura individuale.Ma quest’aura, la sigla estremamente complessa, inconfondibile, dell’odore personale, era comunque impercettibile per la maggior parte degli uomini.. i più non sapevano di possederla, oppure facevano di tutto per nasconderla sotto i vestiti e sotto odori artificiali alla moda.Conoscevano bene soltanto quell’aroma di fondo, quell’esalazione primitiva d’umano, in essa soltanto si sentivano e si sentivano protetti, e chiunque emanasse quell’ effluvio comune era da essi considerato come un loro pari.Fu uno strano profumo quello che Grenouille inventò quel giorno. Fino allora non ce n’era mai stato uno più strano.Non aveva l’odore di un profumo, bensì di un uomo che ha un profumo. Quando uscì per strada, fu colto da un’improvvisa paura, perché sapeva di emanare un odore umano per la prima volta in vita sua. A lui però sembrava di puzzare, di puzzare in modo assolutamente ripugnante. E non riusciva a figurarsi che altri non trovassero ugualmente ripugnante il suo odore, e non osò dirigersi subito verso l’osteria, dove lo stavano aspettando.Gli sembrava meno rischioso prima sperimentare la nuova aura in un ambiente anonimo. Fin dall’infanzia era abituato al fatto che le persone che gli passavano accanto non lo notavano in alcun modo, non per disprezzo, come aveva creduto un tempo, ma perché proprio non si accorgevano della sua esistenza. Non c’era stato spazio intorno a lui, non onda che lui mandasse nell’atmosfera, non c’era stata ombra, per così dire, che avesse potuto gettare sul volto degli altri.Ma ora, Grenouille avvertì e constatò con chiarezza – e ogni volta che lo constatava era pervaso da un forte sentimento d’orgoglio - che esercitava un effetto sulle persone. Quando passò accanto a una donna china sul bordo di una fontana, notò che essa alzava un attimo il capo per vedere chi fosse e poi, evidentemente tranquillizzata, si volgeva di nuovo verso la propria secchia. I bambini che incontrava si facevano indietro, non per paura, ma per fargli posto; e anche quando uscivano di corsa dall’ingresso laterale di una casa e urtavano bruscamente contro di lui, non si spaventavano, ma sgusciavano via con naturalezza, come se avessero avuto il presentimento della sua persona che si avvicinava.Grenouille si mescolò alla folla. Diede spintoni, s’insinuò, voleva andare dove le persone erano più fitte, a contatto di pelle voleva averle, voleva sfregare il proprio profumo direttamente contro i loro nasi. E in quello spazio angusto e stipato allargò braccia e gambe e si slacciò il colletto, affinché il profumo potesse fuoriuscire liberamente dal suo corpo… e immensa fu la sua gioia quando si accorse che tutti quegli uomini e donne e bambini pigiati intorno a lui inalavano il suo odore come quello di un loro simile e che accettavano lui, Grenouille, la prole del diavolo, in mezzo a loro, come uomo fra uomini.
Il profumo. Patrick Suskind - Edizioni TEA

AZZURRINA: UNA LEGGENDA ITALIANA
Solitamente padre e figlia sono indicati col cognome Malatesta, famiglia signorile di Rimini che allora controllava anche Montebello, ma non si hanno fonti storiche che sanciscano tale parentela. Scomparsa prematuramente alimenta una leggenda molto conosciuta in Romagna.
La leggenda di Azzurrina sarebbe stata tramandata oralmente per tre secoli, presumibilmente venendo di volta in volta distorta, ampliata, abbellita. Solo nel 600 un parroco della zona la mise per iscritto assieme ad altre leggende e storie popolari della Val Marecchia.
Guendalina era albina. La superstizione popolare del tempo collegava l’albinismo con eventi di natura magica se non diabolica. Per questo il padre aveva deciso di farla sempre scortare da un paio di guardie e non la faceva mai uscire di casa per proteggerla dalle dicerie e dal pregiudizio popolare.
La madre le tingeva ripetutamente i capelli con pigmenti di natura vegetale estremamente volatili. Questi, complice la scarsa capacità dei capelli albini di trattenere il pigmento, avevano dato alla bimba riflessi azzurri che ne originarono il soprannome di Azzurrina.
La leggenda narra che il 21 giugno del 1375, nel giorno del solstizio d’estate, Azzurrina giocava nel castello di Montebello con un palla di stracci mentre fuori infuriava un temporale. Era vigilata da due armigeri di nome Domenico e Ruggero. Secondo il resoconto delle guardie la bambina inseguì la palla caduta all’interno della ghiacciaia sotterranea. Avendo sentito un urlo le guardie accorsero nel locale entrando dall’unico ingresso ma non trovarono traccia della bambina. Il suo corpo non venne più ritrovato.
La leggenda vuole che il fantasma della bambina sia rimasto intrappolato nel castello e che torni a farsi sentire nel solstizio d’estate di ogni anno lustro (cioè che finisce per 0 e 5).
Azzurrina, il fantasma di Montebello

PER INFORMAZIONE
Raising a child with albinism. A guide to the early years
Tutti i problemi cruciali cui si trovano di fronte i genitori disorientati dalla nascita di un bambino albino vengono trattati con chiarezza e grande praticità, in un linguaggio semplice, accessibile anche a chi abbia una conoscenza elementare della lingua inglese.
Le immagini dei bambini albini riportate nel libro sono molto belle e rasserenanti: costituiscono da sole una parte del testo e un buon motivo per richiederlo.
Questi gli argomenti:
1)Accogliere un bambino con albinismo nella vostra vita
2)Cos’è l’albinismo
3)Quale impatto avrà l’albinismo sulla sua crescita?
4)Stimolare la vista
5)Professionisti della salute ed esame oculistico
6)Opzioniterapeutiche
7)Fornitori di servizi*
8)Servizi di intervento precoce*
9)Tecnologie assistite1
0)Aspetti sociali dell’albinismo
11)Albini di colore
12)Protezione solare
13)Vostro figlio in classe1
4)Lo sport e i bambini con albinismo
* La situazione descritta è relativa agli Stati Uniti ma un raffronto con il nostro paese è ampiamente possibile.
Raising a child with albinism. A gude to the early years, NOAH

NUOVI RACCONTI
-Nora, vuoi rivelarci a che età è iniziato il tuo rapporto con la musica?
Nora passa tutto il giorno a giocare con quell’affare… Ripete mia madre, affabile e distratta. Credo che le piaccia la musica. Non dovrebbe stare sempre sola, sempre in casa, sempre nella penombra. Andiamo pure, la troveremo al nostro ritorno dove l’abbiamo lasciata, stanne certo.
-Avevo cinque anni, ancora non andavo a scuola.
-Nella tua famiglia ci sono altri musicisti?
Proprio non si capisce da chi abbia ereditato un simile dono (dono?). Buffa bambina aliena. Strana, strana anche in questo. Quell’affare è troppo grande per lei, finirà per storcersi la schiena. Devo proprio comprarle qualcosa di più adatto. Ma cosa?
-No, io sono l’unica.
-E come mai proprio il violoncello, uno strumento, dopotutto, meno comune per i bambini rispetto ad altri, come il pianoforte o il violino?
Una domenica di pioggia. La porta della mia stanza è socchiusa; fa già quasi buio, me ne sto distesa sul letto ad ascoltare le gocce che battono sul tetto come i becchi di minuscoli uccelli. A un tratto qualcuno entra piano, senza fare rumore. Capisco che si tratta di Emilio dall’odore di sigaretta e di acqua di colonia. D’altra parte, chi altro potrebbe essere? I miei genitori, le mie sorelle sono tutti di là, nel soggiorno, insieme a decine di invitati. Mangiano, bevono, discutono. Non può essere che lui. Altri angeli, in giro, non ce ne sono: si potrebbe cercare per giorni e non se ne troverebbero. Emilio accende la luce. Ha in mano un grande pacchetto di cui non mi importa niente. Anzi, preferirei che non ci fosse perché è qualcosa tra di noi. Mi piacerebbe che fossimo soli. Ma per nessun motivo al mondo vorrei fargli dispiacere, così gli butto le braccia al collo e subito dopo, ridendo, strappo il nastro bianco e la carta dorata. Trovo una scatola di legno che racchiude a sua volta un oggetto strano, quasi più alto di me. Magico, senza ombra di dubbio.
-Un giorno Emilio, un amico di mio padre che era molto affezionato a me, mi regalò il suo violoncello. Capii subito che non si trattava di un giocattolo, ma di qualcosa di speciale. Ne fui affascinata e decisi di imparare a suonarlo.
-Fu quest’uomo a insegnarti a suonare?
Ogni singolo giorno, ogni singola ora, ogni singolo minuto passati a aspettare il sabato pomeriggio. Emilio mi ascolta suonare e ogni tanto accarezza appena i miei capelli del colore della neve. E’ una mano tesa verso la mia solitudine. Solitudine senza dolore, senza emozioni, senza domande. Le domande verranno più tardi. “Sono belli i tuoi capelli, Nora” – mi dice. Ma io non gli credo, perché a scuola, per colpa dei miei capelli, mi chiamano la vecchia bambina, e io la mia vecchiaia precoce la sento rimbombare come un’eco nel vuoto che ho dentro, dove spuntano solo piante secche e fiori appassiti.
-Sì, Emilio fu il mio primo maestro. Mi ha dato lezione per un paio d’anni, veniva a casa nostra quasi tutti i sabati pomeriggio. Prendeva il tè con i miei genitori poi saliva in camera mia e ci esercitavamo.
-Quand’ è che tu e i tuoi genitori avete deciso di rivolgervi a una scuola di musica? Immagino che questo Emilio abbia potuto condurti solo fino ad un certo punto.
Aspetto, aspetto invano. Ripenso a Emilio tutti i giorni, tutte le notti; mi rompo la testa. Cominciano le emozioni e le domande. Troppe. Mi tornano in mente la sua espressione triste e la paura che a volte impastava la sua voce. Infine lo perdono.
-Sinceramente, non so dire fino a che punto avrebbe potuto portarmi Emilio. Il fatto è che un giorno se ne è andato. E’ sparito, si è volatilizzato nel nulla.
-Allora a chi vi siete rivolti?
Siamo io e il violoncello, e è come essere ancora con Emilio. Nessuno mi accarezza più i capelli ma non ha importanza. I miei genitori mi ripetono distrattamente di passare più tempo all’aria aperta. Mi vestono di tutto punto quando vengono a casa i clienti di papà o le amiche della mamma. Per il resto, mi lasciano in pace. Anna e Carlotta, le mie sorelle più grandi, appartengono a un altro mondo, che non si incontra mai con il mio. Ma la mattina devo andare a scuola, e a scuola i compagni ridono di me e gli adulti mi trattano con finta compassione e distacco. Una mattina, non so più per quale motivo, entro in un’aula dove ci sono dei bambini e degli insegnanti. Appena apro la porta, uno scroscio di risate mi investe come un treno che mi fa a pezzi. E’ una bella giornata, la stanza è inondata di luce e io, abbagliata, non vedo niente. Immagino le facce, i denti, le bocche da cui provengono quelle risate. Non mi chiedo perché stanno ridendo. Lo so già, l’ho sempre saputo anche se nessuno gli ha mai dato un nome. Gli adulti non dicono niente. Non vedo neppure loro, so che ci sono ma non li vedo e anche di loro devo immaginare l’espressione impassibile, solo appena alterata da una smorfia di pietà. Ci sono state altre mattine così, altre ce ne saranno. Ma a casa, ad aspettarmi, c’è l’anima di Emilio imprigionata nel violoncello, e come per incanto tutto torna a posto.
-Sul momento miei genitori non si rivolsero a nessuno. Non si erano resi conto che per me il violoncello era una cosa seria. Credevano che si trattasse solo di un gioco, di una stramberia di Emilio che in poco tempo sarebbe sparita dalla nostra casa come era sparito lui. Io però ho continuato ad esercitarmi da sola, tutti i giorni.
-Ma alla fine ti avranno pur fatto prendere lezione, non vorrai dirci che sei un’autodidatta!
Gli anni scivolano via uno dopo l’altro quasi silenziosi, accompagnati solo dal suono roco e malinconico del mio strumento che stringo tra le gambe come un amante. Ogni tanto qualcuno mi chiama, ma resta lontano.
-No, niente affatto. Mio padre, quando si è rese che per me la musica era davvero importante, cercò un’insegnante qualificata. Poi, all’età di quindici anni, mi hanno iscritta al conservatorio, e i miei studi li ho proseguiti lì. Ma il più ritengo di averlo fatto da sola: sono state le interminabili ore passate nella mia stanza, ad esercitarmi, che mi hanno permesso di fare il salto.
-D’accordo. Però devi raccontarci che fine ha fatto Emilio.
Una telefonata, di notte, molto tardi. Ancora la stessa voce, bassa, inconfondibile. I debiti mi erano entrati addosso come spine. Giocavo ogni notte, e ogni notte perdevo. Ho bruciato tutto. Ho bruciato anche te. Potrei dirti il contrario, ma mentirei. Da quando sono arrivato quaggiù, non ti ho mai pensata, neppure una volta. Buffo vero? L’avresti mai immaginato? Ma l’altro giorno ti ho vista in televisione. Mi ha fatto uno stranio effetto trovarti cresciuta: una parte di me era certa che saresti rimasta bambina per sempre. Sentendoti suonare ho pianto, così ho deciso di scriverti. Ma tu non cercarmi. E tutto qui, non c’è altro. La tua stanza nella penombra, un violoncello troppo grande per una bambina di soli cinque anni, i tuoi bellissimi capelli bianchi di cui ti vergognavi, e che ti accarezzavo facendoti arrossire. E’ questo tutto quello che siamo stati. Non c’è altro, credimi.
-Emilio mi ha telefonato qualche mese fa spiegandomi che era dovuto partire all’improvviso per un affare importante, di cui all’epoca non poteva parlare con nessuno. Adesso vive in Brasile, è molto ricco. Mi ha confessato di non aver mai smesso di pensare a me, e di aver seguito passo passo la mia carriera di violoncellista.
-Nora, cambiando argomento, vorresti parlarci del tuo primo amore?
Giorgio, perdutamente innamorato di me, mi aspetta all’uscita del conservatorio con un mazzo di fiori. Mi vuole parlare, gli trema la voce. Carlo cammina accanto a me nei pomeriggi d’autunno e mi racconta del suo progetto di diventare dottore o veterinario. Daniele mi ascolta suonare silenzioso, di nascosto, credendo che io non me ne accorga. Claudio mi chiede di sposarlo in un caldissimo pomeriggio d’agosto, al mare, davanti a un enorme gelato di frutta, quasi all’ora del tramonto. Ma io ho in testa solo Emilio. Emilio, e il nostro violoncello.
-Ve ne parlerei volentieri, ma credo di non averlo ancora trovato. Ho avuto delle storie, ma ripensandoci a posteriori, non userei la parola amore.
-Ti faccio una domanda forse un po’ personale. Come tu stessa hai talvolta ricordato, tu hai dei problemi di vista legati a una malattia genetica… Ti andrebbe di parlarne, e magari di spiegare se questo ha reso la tua carriera più faticosa oppure no?
La ragazzina albina che studia violoncello. Coraggiosa, senza dubbio. La ragazzina albina non vede bene. Pare che abbia difficoltà a leggere le note. Sorprendente. Una memoria sorprendente per la musica. Non legge, ricorda. Sorprendente. Coraggiosa. Non arriverà lontano, ma è coraggiosa. Non avrai paura della ragazzina albina spero. No, certo. Lei non può… Eppure…
-Non è sempre stato facile. Ma in effetti preferirei non parlarne. Scusami.
-Nessun problema! Dicci piuttosto quando sarà il tuo prossimo concerto.
-Tra un mese esatto, a New York
-Grazie Nora, in bocca al lupo. Un applauso per la bellissima, per la bravissima Nora, violoncellista romana di fama mondiale.
Il trucco ormai deve essersi sciolto del tutto. Il sangue esce dalle ferite. Presto annegheremo tutti. Il tuo vestito rosa confetto non ti servirà a restare a galla, e nemmeno questi stupidi applausi. Annegheremo tutti.
INDICE
PREFAZIONE
INTRODUZIONE
ORRORE E SPLENDORE
- Non figlio di uomo, ma degli angeli: Noè
Libro di Enoch; Apocalisse 1-14
- Bianca alba mia
Madrigali, Torquato Tasso
- Bionda testa forestiera
L'isola di Arturo, Elsa Morante
- Orrore del bianco
Moby Dick, H. Melville
- Occhi gelidi
Il bordo vertiginoso delle cose, G. Carofiglio
LA DIVERSITA' RACCONTATA IN MODO REALISTICO
- Una disgrazia per mia madre
La vita accanto, Mariapia Veladiano
- Una luminescenza impressionante
Nettare in un setaccio, Kamala Markandaya
- Una come me
Come pietre nel fiume, Ursula Hegi
- Storia minima
La lampada di Aladino, Luis Sèpulveda
- Sul pregiudizio
Vita dei campi-Rosso Malpelo, Giovanni Verga
- L'isola dei senza colore
L'isola dei senza colore, Oliver Sacks
- Luna
Chi manda le onde, Fabio Genovesi
- August
Wonder, R.J. Palacio
LA DIVERSITA' COME CHIAVE DI LETTURA
- L’odore dell’umano
Il profumo, Patrick Suskind
- L’uomo invisibile
L'uomo invisibile, H. G. Wells
- L’unico specchio della casa
Il paese d'ottobre, Ray Bradbury
- Un pipistrello saggio
Il fantastico volo di ali d'argento, Kemeth Oppel
- La pagina bianca
Ultimi racconti, Karen Blixen
- Bianco, puro, bellissimo
Il codice da Vinci, Dan Brown
- “… dentro restavo pallido…”
Una storia di amore e di tenenbre, Amos Oz
- Il bianco di Kandinskij
Lo spirituale nell'arte, V.V. Kandinskij
- Il brutto anatroccolo
Il brutto anatroccolo, Hans Christian Andersen
- Me pallido
Luglio, Valerio Magrelli
AZZURRINA: UNA LEGGENDA ITALIANA
- Azzurrina Malatesta
- Azzurrina: una fiaba
Azzurrina, Angela Nanetti
- Azzurrina e la visitatrice
Non restate in silenzio, Adriana Lorenzi
PER INFORMAZIONE
- Far crescere un bambino con albinismo. Una guida per i primi anni
Raising a child with albinism. A gude to the early years, NOAH
- Siamo solo noi
Siamo solo noi, Margherita De Bac
- Tutto sul bianco
I colori del nostro tempo, Michel Pastoureau
- Bianco su nero
Le civette e altre creature della notte, Desmond Morris
NUOVI RACCONTI
- L'intervista, Nora Gatti
- Alba viola, Cinzia Cimatti
- In un villaggio d'Africa, Rosa Pellegrino
- L'albino e il tumuto, Adrian Bravi
- Racconto senza chiaro luna, Serena Tubertini
PREFAZIONE
INTRODUZIONE
ORRORE E SPLENDORE
• Non figlio di uomo, ma degli angeli: Noè
Libro di Enoch; Apocalisse 1-14
• Bianca alba mia
Madrigali, Torquato Tasso
• Bionda testa forestiera
L'isola di Arturo, Elsa Morante
• Orrore del bianco
Moby Dick, H. Melville
LA DIVERSITA' RACCONTATA IN MODO REALISTICO
• Una disgrazia per mia madre
La vita accanto, Mariapia Veladiano
• Una luminescenza impressionante
Nettare in un setaccio, Kamala Markandaya
• Una come me
Come pietre nel fiume, Ursula Hegi
• Storia minima
La lampada di Aladino, Luis Sèpulveda
• Sul pregiudizio
Vita dei campi-Rosso Malpelo, Giovanni Verga
• L'isola dei senza colore
L'isola dei senza colore, Oliver Sacks
• Luna
Chi manda le onde, Fabio Genovesi
• August
Wonder, R.J. Palacio
LA DIVERSITA' COME CHIAVE DI LETTURA
• L’odore dell’umano
Il profumo, Patrick Suskind
• L’uomo invisibile
L'uomo invisibile, H. G. Wells
• L’unico specchio della casa
Il paese d'ottobre, Ray Bradbury
• Un pipistrello saggio
Il fantastico volo di ali d'argento, Kemeth Oppel
• La pagina bianca
Ultimi racconti, Karen Blixen
• Bianco, puro, bellissimo
Il codice da Vinci, Dan Brown
• “… dentro restavo pallido…”
Una storia di amore e di tenenbre, Amos Oz
• Il bianco di Kandinskij
Lo spirituale nell'arte, V.V. Kandinskij
• Il pulcino più amato dalle italiane: Calimero
Paola Elia Cimatti
• Il brutto anatroccolo
Il brutto anatroccolo, Hans Christian Andersen
• Me pallido
Luglio, Valerio Magrelli
AZZURRINA: UNA LEGGENDA ITALIANA
• Azzurrina Malatesta
• Azzurrina: una fiaba
Azzurrina, Angela Nanetti
• Azzurrina e la visitatrice
Non restate in silenzio, Adriana Lorenzi
PER INFORMAZIONE
• Far crescere un bambino con albinismo. Una guida per i primi anni
Raising a child with albinism. A gude to the early years, NOAH
• Siamo solo noi
Siamo solo noi, Margherita De Bac
• Tutto sul bianco
I colori del nostro tempo, Michel Pastoureau
• Bianco su nero
Le civette e altre creature della notte, Desmond Morris
NUOVI RACCONTI
• L'intervista, Nora Gatti
• Alba viola, Cinzia Cimatti
• Vado via per sempre, Paola Elia Cimatti
• In un villaggio d'Africa, Rosa Pellegrino
• L'albino e il tumuto, Adrian Bravi
• Bianchi della memoria. Ricordare e raccontare, Paola Elia Cimatti
• Racconto senza chiaro luna, Serena Tubertini
 I dieci racconti che compongono la raccolta Lo sguardo di Bianca, rimasti a lungo chiusi nel cassetto dell’autrice, sono incentrati sulla figura di una donna che si distacca dal suo ambiente di origine per andare incontro a una vita più libera e tutta da inventare in un periodo storico, quello del Sessantotto, segnato da profondi cambiamenti.
I dieci racconti che compongono la raccolta Lo sguardo di Bianca, rimasti a lungo chiusi nel cassetto dell’autrice, sono incentrati sulla figura di una donna che si distacca dal suo ambiente di origine per andare incontro a una vita più libera e tutta da inventare in un periodo storico, quello del Sessantotto, segnato da profondi cambiamenti.
Il percorso della protagonista è complicato da una condizione genetica particolare, che rende i suoi capelli trasparenti e la vista debole, tanto da non riuscire a riconoscere le persone che l’avvicinano. Di vitale importanza è dunque per lei mettere a fuoco il tema della diversità, come e quanto l’aspetto può determinare il destino della persona in una comunità, e riflettere sulla trasformazione degli stereotipi sociali con cui le donne sono tenute a confrontarsi. L’avvincente ritmo narrativo rivela la profondità di analisi di un io sospeso alla ricerca dell’affermazione della propria identità, resiliente e impegnata, spiccatamente femminile e poetica.
La prima consisteva nel pensiero che una comunità di nuova formazione ha bisogno di un patrimonio comune di storie, immagini, personaggi cui fare riferimento. Questo aiuta a identificarsi, trovare antenati e familiari immaginari, dissolve la sensazione di essere un caso unico (monstrum), oppure di non esistere, dato che nessuno ne ha mai parlato. Così, mi misi a raccogliere i “personaggi albini” in letteratura, scoprendo che sono molti di più, e molto più interessanti, di quanto immaginavo, e non solo personaggi secondari, di contorno, ma veri e propri protagonisti. Aggiunsi anche storie di “diversità”, di persone che erano state pesantemente condizionate nella loro vita da pregiudizi sul loro aspetto fisico. Il materiale che raccolsi allora, e quello che trovai in seguito grazie alla collaborazione di amici di buone letture, è tuttora visibile su questo sito.
La seconda idea era proiettata sul futuro: non solo raccogliere quello che era stato detto (anche se nessuno lo aveva mai visto in quella prospettiva), ma anche aggiungere, andare avanti, dire cose nuove. Così lanciai la sezione “Nuovi racconti”, cui tutti gli aderenti all’associazione – ma anche altri – erano invitati a dare il loro contributo, scrivendo le loro esperienze, in modi e forme scelti da loro. Alcuni di questi racconti si possono ancora leggere sul sito.
Naturalmente, cominciai io, e scrissi alcuni racconti che oggi, con cambiamenti e rielaborazioni, fanno parte della raccolta “Lo sguardo di Bianca” (“Vado via per sempre”, “Il pulcino nero” etc…).
Questi racconti, nonostante l’apprezzamento che mi giunse da diverse parti, non avevo mai pensato di pubblicarli: mi sentivo fortemente in imbarazzo nel raccontare “i fatti miei”, anche perché l’atteggiamento abituale che tengo nei confronti della mia patologia è quello di minimizzare, fare finta di niente, non far pesare, spacciarmi per una persona che non ha niente di diverso, al punto di non chiedere aiuto neppure quando ne avrei bisogno. Perché dunque raccontare a estranei, con il rischio di alimentare distanze, commiserazione, fastidio? Avevo notato che, se a volte mi mettevo a riferire esperienze sul tema, l’interesse dei miei interlocutori si spegneva rapidamente, le mani diventavano irrequiete, gli sguardi si rivolgevano altrove, qualcuno cambiava discorso, avevo l’impressione di finestre che venissero chiuse. Evidentemente si trattava di situazioni che alla maggior parte delle persone non capitano, per di più segnate da accenti dolorosi, che nemmeno l’ironia e l’umorismo del racconto riusciva a rendere accettabili.
C’era però un altro aspetto che mi inquietava e mi impediva di chiudere definitivamente i racconti in un cassetto: dentro al cassetto continuavano ad agitarsi e a scalpitare.
Era quello che chiamo l’“aspetto testimonianza”.
Sia con l’antologia che con i racconti avevo seguito il principio che confrontarsi con i propri non-detti e punti oscuri potesse essere utile ai potenziali lettori. Sono convinta del valore terapeutico di scrivere e leggere. Mi trovavo allora a un certo livello di presa di coscienza e di elaborazione e volevo mettere i risultati della mia ricerca a disposizione di chi volesse usarli come lente di ingrandimento o lampada da minatore. Volevo aggiungere la consapevolezza della mia condizione al patrimonio dell’Umanità. Sono convinta che ognuno/a debba sviluppare le tematiche esistenziali di cui si trova investito/a. Ma questo può essere difficile, può capitare di non trovare il modo per poterlo fare. Così il cassetto rimase chiuso e la ruggine cominciò a fiorire sulle sue cerniere.
Fino al giorno in cui lessi il bando di concorso del premio intitolato a Clara Sereni, che era stata per lungo tempo la mia scrittrice preferita, per vari motivi, ma anche per il modo in cui scrive di situazioni gravi e anomale con leggerezza, ironia, umorismo (nei suoi racconti c’è il “manicomio”, ma c’è anche la “primavera”!). Lessi che sarebbero stati particolarmente graditi i racconti di esperienze femminili di impegno, inclusione e resilienza. Allora sentii suonare un campanello e le cerniere del mio cassetto scricchiolarono di impazienza. Approfittando del vuoto che mi si era aperto intorno grazie (sì, dico grazie!) alla clausura di marzo, mi misi a rileggere, correggere, ritoccare, riscrivere, contare lettere e spazi per rendere la mia opera adatta a partecipare al concorso.

I dieci racconti che compongono la raccolta Lo sguardo di Bianca, rimasti a lungo chiusi nel cassetto dell’autrice, sono incentrati sulla figura di una donna che si distacca dal suo ambiente di origine per andare incontro a una vita più libera e tutta da inventare in un periodo storico, quello del Sessantotto, segnato da profondi cambiamenti.
Il percorso della protagonista è complicato da una condizione genetica particolare, che rende i suoi capelli trasparenti e la vista debole, tanto da non riuscire a riconoscere le persone che l’avvicinano. Di vitale importanza è dunque per lei mettere a fuoco il tema della diversità, come e quanto l’aspetto può determinare il destino della persona in una comunità, e riflettere sulla trasformazione degli stereotipi sociali con cui le donne sono tenute a confrontarsi. L’avvincente ritmo narrativo rivela la profondità di analisi di un io sospeso alla ricerca dell’affermazione della propria identità, resiliente e impegnata, spiccatamente femminile e poetica.
La prima consisteva nel pensiero che una comunità di nuova formazione ha bisogno di un patrimonio comune di storie, immagini, personaggi cui fare riferimento. Questo aiuta a identificarsi, trovare antenati e familiari immaginari, dissolve la sensazione di essere un caso unico (monstrum), oppure di non esistere, dato che nessuno ne ha mai parlato. Così, mi misi a raccogliere i “personaggi albini” in letteratura, scoprendo che sono molti di più, e molto più interessanti, di quanto immaginavo, e non solo personaggi secondari, di contorno, ma veri e propri protagonisti. Aggiunsi anche storie di “diversità”, di persone che erano state pesantemente condizionate nella loro vita da pregiudizi sul loro aspetto fisico. Il materiale che raccolsi allora, e quello che trovai in seguito grazie alla collaborazione di amici di buone letture, è tuttora visibile su questo sito.
La seconda idea era proiettata sul futuro: non solo raccogliere quello che era stato detto (anche se nessuno lo aveva mai visto in quella prospettiva), ma anche aggiungere, andare avanti, dire cose nuove. Così lanciai la sezione “Nuovi racconti”, cui tutti gli aderenti all’associazione – ma anche altri – erano invitati a dare il loro contributo, scrivendo le loro esperienze, in modi e forme scelti da loro. Alcuni di questi racconti si possono ancora leggere sul sito.
Naturalmente, cominciai io, e scrissi alcuni racconti che oggi, con cambiamenti e rielaborazioni, fanno parte della raccolta “Lo sguardo di Bianca” (“Vado via per sempre”, “Il pulcino nero” etc…).
Questi racconti, nonostante l’apprezzamento che mi giunse da diverse parti, non avevo mai pensato di pubblicarli: mi sentivo fortemente in imbarazzo nel raccontare “i fatti miei”, anche perché l’atteggiamento abituale che tengo nei confronti della mia patologia è quello di minimizzare, fare finta di niente, non far pesare, spacciarmi per una persona che non ha niente di diverso, al punto di non chiedere aiuto neppure quando ne avrei bisogno. Perché dunque raccontare a estranei, con il rischio di alimentare distanze, commiserazione, fastidio? Avevo notato che, se a volte mi mettevo a riferire esperienze sul tema, l’interesse dei miei interlocutori si spegneva rapidamente, le mani diventavano irrequiete, gli sguardi si rivolgevano altrove, qualcuno cambiava discorso, avevo l’impressione di finestre che venissero chiuse. Evidentemente si trattava di situazioni che alla maggior parte delle persone non capitano, per di più segnate da accenti dolorosi, che nemmeno l’ironia e l’umorismo del racconto riusciva a rendere accettabili.
C’era però un altro aspetto che mi inquietava e mi impediva di chiudere definitivamente i racconti in un cassetto: dentro al cassetto continuavano ad agitarsi e a scalpitare.
Era quello che chiamo l’“aspetto testimonianza”.
Sia con l’antologia che con i racconti avevo seguito il principio che confrontarsi con i propri non-detti e punti oscuri potesse essere utile ai potenziali lettori. Sono convinta del valore terapeutico di scrivere e leggere. Mi trovavo allora a un certo livello di presa di coscienza e di elaborazione e volevo mettere i risultati della mia ricerca a disposizione di chi volesse usarli come lente di ingrandimento o lampada da minatore. Volevo aggiungere la consapevolezza della mia condizione al patrimonio dell’Umanità. Sono convinta che ognuno/a debba sviluppare le tematiche esistenziali di cui si trova investito/a. Ma questo può essere difficile, può capitare di non trovare il modo per poterlo fare. Così il cassetto rimase chiuso e la ruggine cominciò a fiorire sulle sue cerniere.
Fino al giorno in cui lessi il bando di concorso del premio intitolato a Clara Sereni, che era stata per lungo tempo la mia scrittrice preferita, per vari motivi, ma anche per il modo in cui scrive di situazioni gravi e anomale con leggerezza, ironia, umorismo (nei suoi racconti c’è il “manicomio”, ma c’è anche la “primavera”!). Lessi che sarebbero stati particolarmente graditi i racconti di esperienze femminili di impegno, inclusione e resilienza. Allora sentii suonare un campanello e le cerniere del mio cassetto scricchiolarono di impazienza. Approfittando del vuoto che mi si era aperto intorno grazie (sì, dico grazie!) alla clausura di marzo, mi misi a rileggere, correggere, ritoccare, riscrivere, contare lettere e spazi per rendere la mia opera adatta a partecipare al concorso.
DIVERSITA' e BULLISMO

Luna e Zot
Da leggere insieme, grandi e piccoli
"Non giudicare una persona dalla faccia"
"Ciò che è bello è buono, ciò che è buono presto sarà bello"
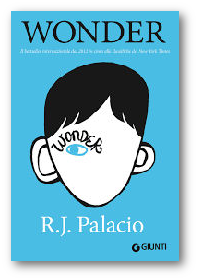
August

"Sento sulle spalle il peso degli sguardi
impauriti e schifati
per il colore della mia pelle"
Il ragazzo che l'ha detta si è tolto la vita, era di origine etiope (scuro, come i nordafricani, non nero), adottato da una famiglia italiana, aveva doti, come calciatore e ballerino, ma non gli sono bastate a fargli superare il senso di "non essere dei nostri" che gli hanno fatto pesare.
Anche noi (persone albine), d'altra parte, veniamo considerate "non dei nostri", cioè straniere ("...ma tu non sei italiana...di dove sei? Do you speak English? Sprechen Sie Duetch? Uffa, che due scatole!!!)
E nessuno capiva come mai mi arrabbiassi e a volte allungassi qualche manrovescio ai più insistenti: allora il "catcalling" (oggi si chiama così) era considerato una forma di corteggiamento, di cui le ragazze "dovevano" essere contente.
Una cosa buffa è che sono stata "degradata" nella mia nazionalità, che è rimasta straniera, ma è passata da nazioni ricche e vincenti (Inghilterra, Germania, Svezia), esportatrici di turiste e di studentesse, a nazioni più povere (paesi dell'Est), da cui provenivano badanti e donne di servizio.
Paola Èlia
Filastrocca
Pelle Bianca come la cera
Pelle Nera come la sera
Pelle Arancione come il sole
Pelle Gialla come il limone
tanti colori come i fiori.
Di nessuno puoi farne a meno
per disegnare l’arcobaleno.
Chi un sol colore amerà
un cuore grigio sempre avrà.
La pelle di Giovanni Rodari
LUGLIO
Invece luglio taglia luce lama
che abbaglia e incide me pallido
candidato all’esclusione, bruciato
dall’invidia, per chi si abbronza
incolume, mentre io ustionato
decorato di piaghe ho la pelle
che cade da lebbroso, lebbroso della
luce, da questuante dell’ombra
vampiro condannato ad amare luglio
soffrendone il barbarico barbaglio
Valerio Magrelli
Il sangue amaro - Einaudi Editore
Azzurrina è una bambina troppo bianca, che fa paura.
Ma, per sua madre, è diversa dalle altre bambine solo perché è più bella ... e ha doni speciali e meravigliosi
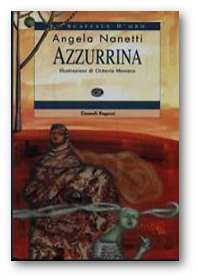
Azzurrina: una fiaba

Azzurrina Malatesta
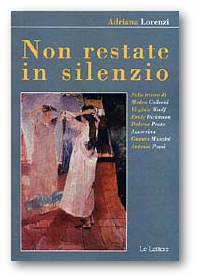
Azzurrina e la visitatrice
Azzurrina di Adriana Lorenzi
Il bianco è quasi il simbolo di un mondo in cui tutti i colori, come principi e sostanze fisiche, sono scomparsi.
ORRORE E SPLENDORE
BIONDA TESTA FORESTIERA -L'isola di Arturo, Elsa Morante
[…] Lui avanzava risoluto, come una vela nel vento, con la sua bionda testa forestiera. […]La prima ragione della sua supremazia su tutti gli altri stava nella sua differenza, che era il suo più bel mistero. . Egli era diverso da tutti gli uomini di Procida, come dire da tutta la gente che io conoscevo al mondo, e anche (o amarezza), da me. Anzitutto, egli primeggiava fra gli isolani per la sua statura, (ma questa sua altezza si rivelava solo al paragone, vedendo lui vicino ad altri. Quando stava solo, isolato, appariva quasi piccolo, tanto le sue proporzioni erano graziose). Oltre alla statura, poi, lo distinguevano dagli altri i suoi colori: era chiaro come le perle. E io vedevo in ciò quasi il segno di una stirpe non terrestre: come s’egli fosse fratello del sole e della luna. I suoi capelli, morbidi e lisci, erano di un colore biondo opaco, che si accendeva, a certe luci, di riflessi preziosi; e sulla nuca, dov’erano più corti, quasi rasi, erano proprio d’oro.. Infine, i suoi occhi, erano di un turchino-violaceo, che somigliava al colore di certi specchi di mare intorbidati dalle nuvole. […]
LA DIVERSITÀ RACCONTATA IN MODO REALISTICO
UNA LUMINESCENZA IMPRESSIONANTE - Nettare in un setaccio, Kamala Markandaya
[…] “Tuo figlio” – dissi, avvicinandole il fagotto, ansiosa.
Lo prese sorridendo e sospirò: “Che bel piccino – disse, fissando con amore il suo visetto – chiaro, come un fiore."
Chiaro! Anche troppo chiaro. Solo lei non vedeva quanto fosse innaturale quella chiarezza, e non notava che i capelli che spuntavano morbidi e radi sulla sua testa erano del colore del chiaro di luna e i suoi occhi erano rosa. Talvolta mi pareva che fosse impazzita: come poteva non vedere quello che agli altri era così evidente, oppure, mi chiedevo, se la sua non fosse una tragica finzione dettata dall’orgoglio materno, sostenuta da chissà quale sforzo sovrumano. Tuttavia, se simulava, simulava bene: nel suo viso non traspariva segno di dolore o di paura. Era felice, come un uccello col suo piccolo che canta, gioisce con lui e lo vezzeggia come il più bel bambino che una donna abbia mai dato alla luce.
Forse, per lei era così: quell’ enorme peso non gravava sulle sue spalle, ma sopra di noi, soprattutto su Nathan. […]
LA DIVERSITÀ COME CHIAVE DI LETTURA
UN PIPISTRELLO SAGGIO - Il fantastico volo di ali d'argento, Kemeth Oppel
Il pipistrello albino vive su una torre: è molto saggio e ha il dono della preveggenza. Con i suoi sensibilissimi ultrasuoni “sente” il vento e gli avvenimenti anche prima che accadano. E’ esperto di erbe medicinali e sa riconoscere le foglie che inducono il sonno e quelle che guariscono le ferite. Grazie al suo aiuto, il viaggio di Ombra continua verso un ritorno cui fa seguito un altro viaggio.
ORRORE E SPLENDORE
ORRORE DEL BIANCO - Moby Dick, H. Melville
[…] E’ questa qualità inafferrabile che rende l’idea della bianchezza […] capace di accrescere quel terrore fino all’estremo. Ne sono prova l’orso bianco polare e lo squalo bianco dei tropici: cos’altro se non la loro bianchezza soffice e fioccosa li rende quegli orrori ultraterreni che sono? [...]
Forse, con la sua indefinitezza, la bianchezza adombra i vuoti e le immensità crudeli dell’universo, e così ci pugnala alle spalle col pensiero dell’annientamento mentre contempliamo gli abissi bianchi della via lattea? Oppure la ragione è che nella sua essenza la bianchezza non è tanto un colore, quanto l’assenza visibile di ogni colore e nello stesso tempo l’amalgama di tutti i colori, ed è per questo motivo che c’è una vacuità muta, piena di significato, in un gran paesaggio di nevi, un omnicolore incolore di ateismo che ci ripugna? [...]
E, andando ancora oltre, ricordiamo che il cosmetico misterioso che produce tutte le tinte del mondo, il gran principio della luce, rimane sempre in se stesso bianco e incolore, e se operasse sulla materia senza mediazione, darebbe a ogni oggetto, anche ai tulipani e alle rose, la sua tinta vuota. [...]
E di tutte queste cose, la balena albina era il simbolo. […]
LA DIVERSITÀ COME CHIAVE DI LETTURA
L’UNICO SPECCHIO DELLA CASA - Il paese d'ottobre, Ray Bradbury
[…] «Ecco che arrivano» disse Cecy, supina nel letto.«Dove sono?» esclamò Timothy dalla soglia.«Alcuni sono sull'Europa, alcuni sull'Asia, altri sulle Isole, altri ancora sul Sud America!» disse Cecy, tenendo chiusi gli occhi dalle lunghe ciglia castane e frementi.Timothy venne avanti sul tavolato nudo della stanza del piano di sopra. «Chi c'è?»«Zio Einar, zio Fry, il cugino William, e vedo Frulda, Hel-gar, zia Morgiana, la cugina Vivian, vedo anche zio Johann! Arrivano tutti a gran velocità!»«Sono alti nel cielo?» gridò Timothy. I suoi occhietti grigi lampeggiavano. In piedi accanto al letto non mostrava più dei suoi quattordici anni. Fuori il vento soffiava, la casa era al buio, rischiarata solo dalle stelle.«Arrivano attraverso l'aria e viaggiando al suolo in molte forme» disse Cecy, nel suo sonno. Non si muoveva, sul letto; pensava internamente e diceva quel che vedeva. «Vedo un essere simile a un lupo che attraversa un fiume scuro, sulle secche, appena a monte della cascata, e il lume delle stelle riluce sulla sua pelliccia. Vedo una foglia secca di quercia che si libra alta nel cielo. Vedo un pipistrellino che vola. Vedo molti altri esseri che corrono sugli alberi delle foreste e sgusciano lungo i rami più alti. Tutti vengono da questa parte!» […]
LA DIVERSITÀ RACCONTATA IN MODO REALISTICO
L'ISOLA DEI SENZA COLORE - L'isola dei senza colore, Oliver Sacks
[…] Mentre tornavamo a piedi all’albergo […] cominciò a imbrunire; la luna, quasi piena, salì alta nel cielo fino a stagliarsi fra i rami di una palma.. In piedi sotto l’albero, Knut la studiava attentamente, con il monoculare, individuando mari e ombre. Poi, abbassando lo strumento e abbracciando con lo sguardo tutto il cielo esclamò: “Vedo migliaia e migliaia di stelle! L’intera galassia!”
“E’ impossibile” – replicò Bob - “ L’angolo sotteso di quelle stelle è sicuramente troppo piccolo, dato che la tua acuità visiva è un decimo del normale”. […]
LA DIVERSITÀ COME CHIAVE DI LETTURA
L’UOMO INVISIBILE - L'uomo invisibile, H. G. Wells
[…] Fu colpito con forza sotto l’orecchio e avanzò barcollando nel tentativo di affrontare il suo invisibile antagonista. Riuscì a tenersi in piedi e sferrò un pugno in aria, poi fu colpito ancora sotto la mascella e cadde riverso a terra ... Kemp afferrò i polsi, udì il suo assalitore lanciare un grido di dolore e poi la vanga dell’operaio volò sopra di lui e colpì qualcosa che emise un tonfo profondo. Kemp sentì una goccia di vapore umido in viso, la stretta alla gola di colpo si allentò, con uno sforzo convulso si liberò, afferrò una spalla che rimase passiva e rotolò sopra il suo avversario, afferrò i gomiti invisibili e li premette a terra. “L’ho preso! – gridò Kemp – aiuto, aiuto! Tenetelo, è qui! Tenetegli i piedi!”Dopo un secondo, ci fu una partecipazione generale alla lotta, e uno che fosse sopraggiunto in quel momento avrebbe pensato che stessero giocando una partita di rugby molto violenta. Non si sentì nessun altro grido dopo quello di Kemp: solo il tonfo dei colpi, il rumore dei piedi e un ansimare pesante.. Poi l’uomo invisibile, con uno sforzo sovrumano, riuscì ad alzarsi. Kemp gli si buttò addosso come un cane su un cervo e una dozzina di mani colpirono e lacerarono quel corpo invisibile... […]
LA DIVERSITÀ RACCONTATA IN MODO REALISTICO
STORIA MINIMA - La lampada di Aladino, Luis Sèpulveda
[…] Verrà? Ne dubito, perché so quant’è difficile vincere una paura che non è paura, una vergogna che non è vergogna, la colpa più innocente. Ne dubito e, per vincere la sfiducia delle ore passate ad aspettare, mi accendo una sigaretta. Ora attiro molto di più gli sguardi dei passanti. E’ sempre così. “Sta fumando”, “Sta mangiando”, “Sta piangendo”. Qualunque cosa faccia è sempre così.
All’improvviso guardo il mazzo di fiori e scopro che la mia mano, invece di reggerli, li stringe, li strangola con quella violenza minima che basta a sconfiggere i loro fragili colli vegetali. Sorrido pensando che sono appassiti in un lasso di tempo davvero minimo, come le bandiere di un esercito altrettanto minimo e sconfitto, e i loro petali cenciosi mi dicono che è ora di intraprendere la ritirata. […]
LA DIVERSITÀ COME CHIAVE DI LETTUR
L’ODORE DELL’UMANO - Il profumo, Patrick Suskind
[…] ”E’ posseduto dal demonio”“Impossibile! E’ assolutamente impossibile che un lattante sia posseduto dal demonio…. Ha forse un cattivo odore?”“Non ha nessun odore”, disse la balia.“Ecco, vedi? Questo è un segno inequivocabile. Se fosse posseduto dal demonio dovrebbe puzzare.”E per tranquillizzare la balia e nel contempo dar prova del proprio coraggio, Terrier sollevò il canestro e se lo mise sotto il naso “Non sento niente di particolare”, disse, dopo aver annusato per un momento “ad ogni modo, mi sembra che dalle fasce provenga un certo odore.”“Non è questo”, disse la balia, brusca, e allontanò il canestro da sé. “i suoi escrementi hanno un buon odore. E’ lui, il bastardo, che non ha odore.”“Perché è sano”, gridò Terrier, “perché è sano, ecco perché non ha odore!. Soltanto i bambini malati hanno odore. Perché dovrebbe puzzare? Puzzano i tuoi figli?”“No”, disse la balia. “I miei figli hanno l’odore che tutti i bambini devono avere”“Dunque tu affermi di sapere che odore dovrebbe avere un bambino, che comunque è pur sempre - questo vorrei ricordartelo, tanto più quando è battezzato – una creatura di Dio? “ […]
LA DIVERSITÀ COME CHIAVE DI LETTURA
LA PAGINA BIANCA - Ultimi racconti, Karen Blixen
[…] Accanto all’antica porta della città sedeva una vecchia color caffè e velata di nero, che si guadagnava da vivere raccontando storie.Diceva: << Volete una storia, mia buona signora, signor mio? Quante storie ho narrate, una più di mille, da quando per la prima volta lasciai che i giovanotti raccontassero a me le loro favole di una rosa rossa, due levigati boccioli di giglio, e quattro serici serpenti flessuosi dall’abbraccio mortale. Fu la madre di mia madre, la bellezza dagli occhi neri, l’amante dai molti amplessi, fu lei che alla fine – vizza come una mela d’inverno e rannicchiata sotto la clemenza del velo – si prese la briga di insegnarmi l’arte del narrare. A lei l’aveva insegnata la madre di sua madre, ed erano entrambe narratrici migliori di me. Ma questo, ormai, non ha più importanza, perché per la gente loro e io siamo diventate una persona sola, e io sono immensamente rispettata perché racconto storie da duecento anni >>.A questo punto, se è ben pagata e di buon umore, continua.<< Con mia nonna >> diceva << ho fatto una scuola dura. […]
..Io sono bianco, un piccolo AFRICANO BIANCO,
nato da genitori AFRICANI NERI.
La mia pelle è bianca perché sono albino.
I miei genitori non mi hanno ucciso,
né abbandonato,
perché sanno che cos’è l’albinismo.
La mia mamma non è stata ripudiata
dal mio papà e dal villaggio
perchè il mio papà e la gente del villaggio
sanno che cos’è l’albinismo.
Sono stato fortunato.
Mi è stata data la possibilità di crescere
e godere dei colori della Mia Terra.
Mi è stata data la possibilità di vivere.
Come me in Africa ce ne sono tanti,
non si contano.
Forse 1 su 2000-5000 abitanti,
a seconda della regione.
Forse di più!
Siamo così tanti che …
nessuno riesce a contarci!
Che cos’è l’albinismo?
L’albinismo è una condizione ereditaria
che si manifesta con l’assenza o la riduzione di un pigmento
– la melanina –
nella pelle, nei capelli, nei peli e negli occhi.
La melanina colora la pelle,
proteggendola dai raggi dannosi del sole,
e consente uno sviluppo normale degli occhi e del sistema ottico.
Siamo AFRICANI BANCHI
perché nella nostra pelle manca la melanina,
che la renderebbe scura,
proteggendola dai raggi dannosi del sole.
Senza la melanina, siamo in pericolo.
Senza la melanina, la nostra vita media non supera i 30 anni.
Cheilite attinica
Se non proteggiamo le labbra
con una crema protettiva a schermo totale,
il sole le attacca…
le desquama e le riempie di piaghe,
che degenerano in carcinoma del labbro.
Cheratosi attinica
Se non proteggiamo le parti del corpo
scoperte ed esposte al sole
– viso, orecchie, cuoio capelluto, collo,
braccia, gambe, mani e piedi –
con una crema protettiva a schermo totale,
il sole le attacca…
le riempie di squame giallastre,
pruriginose e brutte a vedersi,
che degenerano in carcinoma della pelle.
Molti di noi hanno i capelli rasati a zero,
per tenere sotto controllo lo stato delle piaghe
che si formano sul cuoio capelluto,
non protetto da un cappellino.
Sono pochi i medici che curano le piaghe
che si formano sulle parti esposte del nostro corpo.
L’ assistenza sanitaria a noi non è concessa o è scarsa.
Una crema protettiva a schermo totale
proteggerebbe la nostra pelle.
Ma la crema solare costa molto.
Un prezzo proibitivo per molti genitori.
In alcune regioni è perfino introvabile.
Vestiti adatti, foulards e cappellini
proteggerebbero le parti esposte del nostro corpo.
Ma molti di noi hanno, a stento,
un pasto al giorno e un letto su cui dormire.
Fotofobia
I nostri occhi “hanno paura della luce solare”
perché manca la melanina nell’iride e nella retina.
Un paio di occhiali con lenti colorate
impedirebbe al sole di abbagliarci.
Ipovisione
Fin dalla nascita,
la nostra retina manca di una piccola area, la fovea,
i nostri nervi ottici seguono un percorso anomalo
e i nostri occhi sono un po’ ballerini –nistagmo -
E’ sempre colpa della melanina, che non c’è o ce n’è troppo poca!
E così noi vediamo poco.
Ma vediamo!
Non abbiamo bisogno di imparare il Braille.
Sono sufficienti piccole cose…
Un paio di occhiali da vista
ci aiuterebbe a migliorare la nostra visione
di almeno un grado.
Per non parlare poi dei nuovi ausili ottici!
Ma, forse, chiediamo troppo…
Un insegnante che non confonda
la nostra ipovisione con svogliatezza o altro
sarebbe di grande aiuto nell’ apprendimento!
Siamo intelligenti!
Possiamo fare qualsiasi cosa nella vita,
come tutti.
Fuorché lavorare sotto il sole cocente!
Vogliamo imparare.
Prendere un diploma. Magari una laurea.
L’istruzione è importante.
Ci darebbe una possibilità in più nel mondo del lavoro.
La possibilità di non restare ai margini!
Un futuro dignitoso per noi AFRICANI BIANCHI!
Basta alla discriminazione, alle superstizioni,
alle amputazioni , alle uccisioni!
Spieghiamo, a gran voce, alla mia gente
perché siamo bianchi!
Perché non imprigionino,
senza alcuna ragione, la nostra vita!
Basta alla discriminazione nei luoghi di lavoro!
Se da grande uno di noi vorrà fare il cameriere, il medico
o qualsiasi altro mestiere,
lasciateglielo pur fare!
Il nostro essere bianchi non è contagioso!
Basta alla discriminazione nei luoghi pubblici!
Potete sedervi accanto a noi su un autobus!
Potete salutarci dandoci la mano!
Non costituiamo un pericolo per voi!
Lasciateci camminare in pace per le strade della nostra Africa.
Non rincorreteci gioiendo
perché pensate che siamo Bianchi,
per poi rincorrerci insultandoci
perché vi accorgete che siamo AFRICANI BIANCHI!
Voi Tanzaniani, delle regioni del Lago Vittoria;
non uccideteci, non amputateci, non dissanguateci,
per fare amuleti con parti del nostro corpo!
Non date retta agli stregoni!
Amuleti sì fatti non serviranno ad avere fama e ricchezze.
Siamo come voi!
Lasciateci vivere!
AIUTATECI A FARLO CAPIRE ALLA NOSTRA GENTE,
Abbiamo il diritto di sorridere alla vita!
Siamo solo AFRICANI ALBINI!
---
IMMAGINI:
- Albinos in Tanzania by Liron Shimoni
- Albinos in Africa Killed for their organs
(1/2) by tonksred300
- Amazing albino story by Babu Sikare
- My shocking story – Albino Medical
by Discovery TV
- Il canale di lupitanyongo
- Tabu contra Negros Brancos
by jodv1951
MUSICA E MONTAGGIO:
- Aldo Menti. Africa. A. M. Songs & Music
PRESENTAZIONE E TESTO:
- Albinismo News - Rosa Pellegrino - www.albinismo.it
RINGRAZIAMO
Liron Shimoni e quanti, con le loro immagini, ci consentono di vedere ciò che non vediamo. Immagini che suscitano emozioni e che fanno riflettere, immagini che richiamano, istintivamente, in chi le osserva, l’appartenenza ad un unico mondo,
che va difeso e custodito nella sua naturale, casuale, indispensabile, vitale diversità.